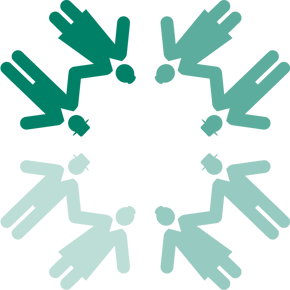Prevenzione

Quando si pensa agli aspetti negativi della vecchiaia, il declino cognitivo è forse quello che più preoccupa le persone. La demenza senile, tuttavia, non è una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento e al di là dei fattori non modificabili, molto si può fare per prevenire e rallentare la sua insorgenza. Ne abbiamo discusso con la Dott.ssa Ester Piovesana, neuroscienziata e scientific writer presso la Swiss Brain Health Foundation.
Dottoressa Piovesana che cos’è la demenza senile?
“Demenza” non è una singola malattia, ma un insieme di sindromi in cui il cervello perde progressivamente diverse funzioni cognitive: memoria, ragionamento, linguaggio, attenzione, capacità di decisione e autonomia nelle attività quotidiane. Oltre ai disturbi di memoria, spesso si alterano le funzioni esecutive, cioè quelle che ci permettono di pianificare, organizzare, prendere decisioni, gestire più compiti insieme, o adattarci a situazioni nuove. Chi ne è colpito può apparire “disorientato” o “meno pratico”, ma in realtà sta perdendo la capacità di orchestrare i propri pensieri.
Altre funzioni spesso trascurate ma importanti:
- Perdita della flessibilità mentale: difficoltà a cambiare idea o strategia di fronte a un imprevisto.
- Riduzione dell’iniziativa e della motivazione (apatia), spesso scambiata per depressione o pigrizia.
- Alterazioni del giudizio e del comportamento sociale, che possono portare a scelte impulsive o inappropriate.
- Difficoltà nel riconoscere le proprie difficoltà (anosognosia), che complica la gestione familiare.
L’età avanzata aumenta il rischio, ma la demenza non è una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento (è bene distinguere invecchiamento fisiologico da invecchiamento patologico). Le forme principali sono: Alzheimer, demenza vascolare, demenza a corpi di Lewy e frontotemporale. Spesso più tipi di demenze possono coesistere (demenza mista).
In che relazione si trova con altre malattie degenerative del cervello, tipo l’Alzheimer?
Abbiamo già detto che la demenza non è una malattia singola, ma un insieme di sindromi causate da diverse patologie che danneggiano il cervello nel tempo.
Tra queste, la malattia di Alzheimer è la forma più comune, responsabile di circa sei casi su dieci.
In Svizzera, si stima che circa 160’000 persone convivano con una forma di demenza e che ogni anno si registrino oltre 30’000 nuovi casi.
Tutte le demenze portano a un progressivo declino delle capacità mentali ma ciascuna ha meccanismi diversi. Nel caso dell’Alzheimer, il cervello si ammala per un processo biologico specifico: due proteine normalmente utili, la beta-amiloide e la tau, cambiano forma e si accumulano dove non dovrebbero.
- L’amiloide si deposita tra i neuroni, disturbando la comunicazione.
- La tau si accumula all’interno delle cellule, rendendole fragili.
Questi depositi interrompono le connessioni cerebrali, provocano infiammazione e morte dei neuroni, e portano gradualmente alla perdita di memoria, orientamento e capacità decisionali.
Le altre malattie neurodegenerative che causano demenza, come la demenza vascolare, la demenza a corpi di Lewy o la demenza frontotemporale hanno origini diverse (piccoli ictus, accumuli di altre proteine o degenerazione delle aree frontali), ma il risultato finale è simile: un cervello che perde progressivamente la sua capacità di funzionare in modo coordinato.
La vecchiaia implica anche un normale declino delle capacità fisiche e cognitive, quando occorre preoccuparsi? Ci sono in questo senso dei campanelli d’allarme?
Piccoli vuoti di memoria possono essere normali. Campanelli d’allarme: perdita di memoria che interferisce con la vita quotidiana, difficoltà a pianificare o risolvere problemi, disorientamento, difficoltà nel linguaggio, smarrirsi in luoghi noti, oggetti riposti in posti assurdi, cambi bruschi di umore o personalità.
Quale sintomatologia presenta la demenza senile?
I sintomi variano a seconda del tipo di demenza, ma condividono un elemento comune: il cervello perde progressivamente la capacità di gestire le funzioni cognitive e comportamentali.
- Nella malattia di Alzheimer i primi sintomi riguardano la memoria episodica (ricordare eventi recenti, nomi o appuntamenti), seguiti da difficoltà nel linguaggio e nell’orientamento.
- Nella demenza vascolare prevalgono problemi di attenzione, pianificazione e funzioni esecutive, spesso con andamento “a gradini” legato a piccoli ictus.
- Nella demenza a corpi di Lewy sono tipiche le fluttuazioni cognitive (giorni “sì” e “no”), le allucinazioni visive e i sintomi simili al Parkinson.
- Nella demenza frontotemporale compaiono precocemente cambiamenti di comportamento, linguaggio e controllo degli impulsi.
Un aspetto oggi molto studiato riguarda il sonno:
in passato si pensava che i disturbi del sonno comparissero solo nelle fasi avanzate, ma le ricerche degli ultimi anni mostrano che alterazioni del ritmo sonno-veglia possono essere tra i primi segnali biologici di una futura demenza.
Durante il sonno profondo, infatti, il cervello elimina “scorie” come la beta-amiloide attraverso il cosiddetto sistema glinfatico. Quando si dorme poco o male, questo meccanismo di “autopulizia” non funziona bene, e le proteine tossiche tendono ad accumularsi più rapidamente.
Per questo insonnia cronica, sonno frammentato o apnea notturna sono oggi considerati fattori di rischio e campanelli d’allarme precoci, non solo sintomi tardivi.
Nelle fasi più avanzate della malattia possono comparire perdita di autonomia, disturbi del sonno più marcati, malnutrizione, cadute e fragilità fisica.
Che decorso ha? Si può rallentare?
La demenza è una condizione progressiva, cioè tende ad avanzare nel tempo, ma il ritmo e la gravità del decorso variano da persona a persona e da tipo a tipo.
Nel caso della malattia di Alzheimer, oggi disponiamo, per la prima volta, di terapie “modificanti la malattia”. Questo significa che non agiscono solo sui sintomi (come facevano i farmaci più vecchi, che miglioravano temporaneamente la memoria o l’attenzione), ma intervengono sui meccanismi biologici che causano la malattia, cercando di rallentare il danno al cervello.
Due farmaci sono già stati approvati:
- Lecanemab (Leqembi): approvato anche in Europa nel 2025, indicato per persone con Alzheimer in fase iniziale.
- Donanemab (Kisunla): approvato negli Stati Uniti nel 2024 e in Europa nel 2025, sempre per forme precoci.
Entrambi mirano a ridurre i depositi di amiloide nel cervello e hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo di circa il 25–30% negli studi clinici, se iniziati molto presto e sotto stretto controllo medico.
Oltre ai farmaci, è ormai chiaro che lo stile di vita ha un impatto diretto sulla salute del cervello.
Attività fisica regolare, una dieta equilibrata, un sonno riparatore, una vita sociale attiva e anche l’uso di apparecchi acustici in caso di perdita dell’udito possono rallentare il declino cognitivo fino al 50% in persone a rischio, come dimostrato da grandi studi internazionali.

Quali sono le cause?
Le cause della demenza dipendono dal tipo di malattia che colpisce il cervello.
Ogni forma ha meccanismi biologici specifici. Tuttavia, non tutte le cause sono note. In molti casi la demenza è multifattoriale, cioè deriva da una combinazione di diversi fattori: genetici, vascolari, metabolici e ambientali, che nel tempo indeboliscono la resilienza del cervello.
Esistono anche casi “misti”, in cui si sommano più meccanismi, ad esempio Alzheimer e danno vascolare nello stesso cervello.
Oltre a questi, diversi fattori di rischio aumentano la probabilità di sviluppare la malattia o di anticiparne la comparsa:
- età avanzata e familiarità genetica;
- ipertensione, colesterolo alto, diabete e obesità;
- fumo, alcol e sedentarietà;
- ipoacusia (perdita dell’udito) e deficit visivo non corretto, che riducono la stimolazione cerebrale;
- isolamento sociale, depressione, traumi cranici e inquinamento atmosferico
Alcuni farmaci aumentano il rischio?
Alcuni farmaci, se assunti per lunghi periodi o in dosi elevate, possono essere associati a un peggioramento della memoria o dell’attenzione negli anziani, ma il rischio dipende sempre dal contesto clinico e dall’equilibrio tra benefici e effetti collaterali.
I farmaci ad azione anticolinergica (come l’ossibutinina, alcuni antidepressivi o antistaminici) possono interferire con i circuiti cerebrali della memoria.
Anche le benzodiazepine, se usate a lungo, sono legate a un maggiore rischio di confusione o declino cognitivo.
Per altri medicinali, come gli inibitori di pompa protonica (per il reflusso), i dati non sono conclusivi: l’uso prolungato va solo rivalutato periodicamente con il medico.
L’importante è non sospendere mai da soli una terapia, ma parlarne con il proprio medico: in molti casi esistono alternative più adatte o dosaggi ridotti.
È possibile prevenire la demenza?
Sì, circa il 45% dei casi può essere prevenuto o ritardato agendo su i fattori modificabili: istruzione, ipoacusia, ipertensione, fumo, obesità, depressione, inattività, diabete, alcol eccessivo, traumi cranici, inquinamento, isolamento sociale, LDL alto, deficit visivi. Contano anche controllo dei fattori vascolari, esercizio fisico, dieta, stimolazione cognitiva e sociale.
Se la prevenzione inizia a 60 anni è ancora efficace?
Sì. Interventi su pressione, diabete, attività fisica, dieta, uso di apparecchi acustici e correzione della vista mostrano benefici anche in tarda età. Non è mai troppo tardi per ridurre il rischio e rallentare il declino.
Quali fattori aumentano il rischio di insorgenza?
Il rischio di sviluppare una forma di demenza aumenta con l’età, ma non dipende solo dall’invecchiamento: è il risultato di una combinazione di fattori genetici, vascolari, metabolici e ambientali che, nel tempo, riducono la “resilienza” del cervello.
Fattori non modificabili:
- Età avanzata: principale fattore di rischio per tutte le demenze.
- Sesso femminile: le donne sono più colpite, in parte per la maggiore longevità.
- Predisposizione genetica: come il gene APOE ε4 per l’Alzheimer o mutazioni familiari più rare in altre forme (frontotemporale).
Fattori modificabili:
- Malattie vascolari e metaboliche: ipertensione, diabete, colesterolo alto, obesità.
- Stili di vita: fumo, abuso di alcol, sedentarietà, alimentazione squilibrata.
- Fattori sensoriali e cognitivi: ipoacusia non trattata, deficit visivo, isolamento sociale e depressione, che riducono la stimolazione cerebrale.
- Traumi cranici ripetuti e inquinamento atmosferico, sempre più riconosciuti come elementi di rischio.
In sintesi, più fattori si sommano, maggiore è la probabilità che una demenza insorga o progredisca più rapidamente, ma agire su quelli modificabili può ridurre il rischio complessivo fino a quasi la metà.
In che misura la genetica gioca un ruolo?
La genetica può influire sul rischio di sviluppare una demenza, ma in modi diversi a seconda del tipo di malattia. Nella maggior parte dei casi non è l’unica causa, bensì un fattore che aumenta la vulnerabilità del cervello, insieme ad ambiente e stile di vita.
In sintesi: la genetica può “predisporre”, ma non “condannare”. Anche chi porta geni di rischio può ridurre la probabilità o ritardare la comparsa della malattia attraverso stile di vita sano, controllo della pressione e del diabete, attività fisica e stimolazione mentale.